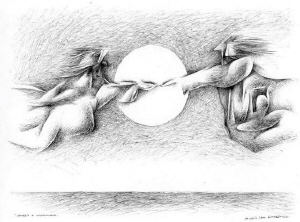|
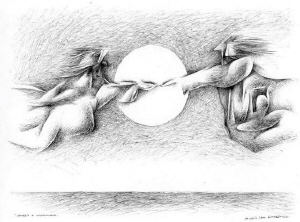
Una lettera di Attilio del Giudice
Se dovessi analizzare stilisticamente l’opera di Andrea
Sparaco, sarebbe come entrare, nottetempo, di nascosto, nella cittadella
fortificata della Critica d’Arte, senza nemmeno un cavallo a dondolo.
Praticamente, col rischio di essere catturato e fucilato sul posto. Insomma non
ho l’attrezzatura per farlo decentemente, né Andrea, che è un artista di
rilevanza nazionale, ne ha bisogno: altri l’hanno fatto con la dovuta
specificità culturale e professionalità. D’altronde, io, per indole e
operatività, mi pongo sul versante dei facitori (lo dico in senso tecnico e
classificatorio) e non degli analisti e dei critici d’arte. Tuttavia, essendo
stato testimone per un certo numero di anni di una vicenda artistica, per molti
versi straordinaria, quella appunto di Andrea, due cose che penso le vorrei
dire. A modo mio, si capisce.
La prima è questa: pochi artisti possono vantare una
produzione così cospicua come quella di Sparaco. Centinaia e centinaia di
disegni, sculture, dipinti, serigrafie, incisioni, collages, assemblages,
grafiche per libri, per riviste, installazioni di opere pubbliche, e con
aperture e flessibilità anche per i linguaggi tecnologici. Un’attività
enorme, senza soste, condotta, infaticabilmente, ogni giorno, e non solo per
urgenze espressive, per necessità interiori, ma anche, e in maniera rilevante,
per una sua disponibilità assoluta a contribuire, col suo lavoro, alle
cosiddette "giuste cause": di carattere politico, sociale, sindacale,
ecologico, di solidarietà umana e così via. Lui non avrebbe mai detto:
"Mo ci ho da fa’, ci ho da consegna’ n’opera de svariati milioni.
Magari se trovo n’attimino, te faccio er disegnuccio" (ho usato la mimesi
romanesca, che meglio si confà a questo tipo di psicologia). No, Andrea non
avrebbe mai pensato in tal guisa. Primi maggio, feste dell’Unità, congressi
sindacali, fame nel mondo, Biafra, libertà per la Grecia, Bolivia, Vietnam,
Black Power, Maggio Francese, Valle Giulia, Divorzio e tanti altri eventi,
lotte, manifestazioni, idealità, giuste cause, appunto, l’hanno visto darsi,
anima e corpo, per contribuire con manufatti artistici, manufatti che potessero
servire, dare un apporto di partecipazione, rendere più leggibili i logo e più
suggestivi, sussidiare i manifesti, esaltare graficamente parole d’ordine,
rinforzare le idee con le immagini. Riuscendo, peraltro, a convogliare e a
coinvolgere altri artisti, che frequentavano il suo studio, allievi e artigiani,
in svariati prodotti e realizzazioni. Da questi incontri, nel suo studio,
nacquero amicizie, amori, note di curriculum professionale e, in alcuni casi, si
delinearono le coordinate dei nuovi talenti e, per alcuni, queste esperienze
furono l’incipit della propria storia o storiella artistica.
Quanto ho detto riguarda un fatto incontrovertibile. Non si
presta all’ambiguità delle formulazioni sulle cifre stilistiche e sui livelli
di artisticità. E’, secondo me, un fatto umano, con una forte valenza morale.
Se si deve parlare di Andrea (certo, nessuno ci obbliga, ma se se ne vuole
parlare), questa è la prima cosa che viene in mente.
La seconda è più problematica. In tutta l’opera di Andrea,
e senza che si registrino defaiances, si ha l’impressione e, talvolta, la
certezza, che permanga, costantemente, un’idea antica dell’armonia, dell’equilibrio
formale e una preziosità nell’elaborazione della materia. Alla base c’è un’ispirazione
che include una collaudata sapienza artigianale e una conseguente fatica di
esecuzione. Voglio dire che Andrea non avrebbe mai affidato la sua poetica a una
sciabolata di nero su bianco o, che devo dire? allo strappo di un manifesto
murale o alla casualità statistica dello sgocciolamento dei colori (è ovvio
che non mi riferisco a un Franz Kline, a un Mimmo Rotella o a un Pollock; semmai
ai tanti imitatori ed epigoni). Gli sarebbe sembrato un cedimento al gusto della
trovata, gli sarebbe parsa, sostanzialmente, una mistificazione, una falsità.
"Mi troverete sempre – ha scritto lui stesso – a pochi centimetri dall’avanguardia".
A pochi centimetri, appunto. Cioè a dire che la sua opera non ha niente a che
vedere con i vecchi accademismi, ma nemmeno si vuole confondere con le modalità
del finto estremismo e col rampantismo che, generalmente, funziona con la
sensibilità dei mercanti, ma non con quella della propria coscienza. Questa
posizione di Andrea può essere discutibile, lo ammetto. E, forse, anche lui l’ammette.
Però è un dato di fatto ed ha anch’esso, in ultima analisi, una sua
dimensione etica. In poche parole, Andrea è l’artista che crede ancora in una
possibile intesa col fruitore. Un’intesa emozionale e intellettuale, non
semplicemente sensoriale. Crede nell’Uomo in quanto tale e non se la sente di
umiliarlo, attraverso la sua opera, con la frustrazione visiva e il cazzotto
nello stomaco, a tutti i costi.
Una decina di giorni fa, mi ha chiamato al telefono (ci
sentiamo due, tre volte l’anno.)
"Devo fare una mostra antologica nel Museo di
Capua.
Vorrei che tu scrivessi del Gruppo. Io cerco di difenderne la memoria, ma con
difficoltà. Molti documenti si sono persi… e poi sono solo…"
"Ma c’è un po’ di tempo? Perché sto lavorando alla
costruzione di un sito internet…"
"Sì, almeno una quindicina di giorni."
Insomma ho detto sì, ho accettato con la solita incoscienza,
una prerogativa che, evidentemente, non mi abbandona. Ho pensato che avrei
finito quel mio lavoro entro una settimana e poi avrei avuto il tempo per
concentrarmi su questa cosa che Andrea mi chiedeva. Quando, però, mi sono messo
a pensare a cosa avrei potuto scrivere, ho capito subito che l’impresa era per
niente facile. Non mancano gli argomenti, né mi sono scordato i fatti, non
completamente, almeno. Ma gli afflussi dell’emozione, sussurri e grida della
memoria… sono stati invadenti. E poi i rischi: il rischio per esempio, delle
rimembranze senili, sempre deformate, sublimate, edulcorate, enfatizzate. Così
sono scattati i meccanismi di difesa: prenderla un po’ alla larga,
argomentando.
L’argomento principe, si sa, è l’idea della Storia.
Concetto Marchesi, il grande latinista, diceva che la Storia insegna, ma non ha
scolari. Nell’amarezza della locuzione, emerge chiaro il concetto che non si
può costruire la vita, senza avere memoria del passato. La vita? La vita
sociale e politica, si capisce. La Storia, quindi, se ha questa funzione è
rivolta ai giovani, a quelli che devono costruire il futuro sociale e politico.
Non certo a quelli che di futuro ne hanno poco o niente. I fatti della storia
devono, però, essere significativi. Devono avere potenzialità di incidenza
nella vita contemporanea. Per esempio: sapere quante volte Hitler andava alla
toilette, non serve a niente, ma sapere dell’Olocausto, altroché se serve
alla costruzione del futuro. Ora, io credo che il meccanismo, di cui ho fatto un
esempio paradossale, valga sia per le grandi comunità e per i grandi eventi,
sia per gli accadimenti piccoli e per le piccole comunità. Voglio dire: gli
accadimenti di uno sparuto gruppo di pittori di oltre trent’anni fa, in una
piccola città di provincia, sono stati così significativi e incidenti da poter
essere oggetto di un’analisi storiografica, puntuale, rigorosa, documentata, e
tale da essere recepita e risultare utile ai giovani della nostra città, nella
fattispecie a giovani artisti e critici d’arte?
Onestamente, per quanto la certezza che serva a niente non
sia proprio matematica, personalmente, penso di no. Ne vogliamo parlare lo
stesso? Parliamone pure! Ma alla buona, senza pretese storiografiche, così,
privilegiando il versante aneddotico.
Dunque il "gruppo", di cui Andrea diceva al
telefono, era un gruppo di pittori che si chiamava Gruppo Studi P. 66 – La
Comune 2. Era nato dalle ceneri di un gruppo più vasto, che Luigi Castellano
(Luca) aveva fondato a Napoli e che mirava a coinvolgere tutti, tutti i pittori
della Campania, sperimentati e giovanissimi alle prime armi. Luca aveva anche
scritto il "manifesto" che conteneva le principali direttrici
ideologiche. Mi ricordo qualche frase: "Per un’operazione di massa che
ponga anche gli artisti al centro delle iniziative e delle lotte…" Era la
proposta. Un po’ sballata, in verità, ma adeguata a cementare differenziate
personalità e a dare a tutti un senso di appartenenza. Luca lo aveva certamente
calcolato.
Luca è stato (ed è) una delle più acuminate intelligenze
del mondo artistico napoletano. All’epoca teneva corsi di semiologia presso la
facoltà di Architettura, poi presso la cattedra di Filosofia Teoretica nel
corso di Filosofia del Linguaggio. Ci parlava, perciò, di Semiotica, di
problematiche epistemologiche, di Roland Barthes e dei gruppi che aveva fondato
(per esempio, il mitico Gruppo 58. Luca, del Pezzo, Biasi, Persico, Fergola, di
Bello). Ci parlava del Living Theatre, di Emilio Villa, delle riviste d’avanguardia
che aveva diretto: Linea Sud, Movimento Sud e poi No, alla quale fummo chiamati
a partecipare. Ci parlava dei maestri della poesia visiva, di Stelio Maria
Martini, di grandi galleristi che dovevamo stuprare. Del Gruppo 63 e di
Sanguineti. Dell’astro nascente Achille Bonito Oliva, che, chissà perché,
dovevamo considerare un avversario ideologico e via di seguito. Mescolava,
sapientemente, notizie e informazioni della cultura alta a un umore partenopeo
di tipo popolaresco, che implicava argomenti sui quartieri spagnoli, il
contrabbando delle sigarette, la pizza coi cicirinielli, femmine di vita e
compagnia bella. Alcune sue battute comiche o sarcastiche, specialmente nei
riguardi del potere, del potere politico e culturale (anche quello del PCI,
verso il quale nutriva, comunque, una marcata abnegazione), sono state
memorabili e fanno ancora parte del lessico dei pittori napoletani.
Naturalmente anche noi ne subivamo la
fascinazione. Lo
abbiamo amato in maniera quasi edipica, con il conseguente patricidio… da
Totem e Tabù, appunto.
La Comune 2. Vi facevamo parte Andrea ed io, con Raffaele
Remino e due giovanissimi di cui avevamo intravisto il talento: Livio Marino e
Paolo Ventriglia. Perché due? Il nome era stato coniato da Luca, che, al
solito, pensava in grande: forse la uno doveva essere la Comune di Parigi…
chissà!
Che faceva ‘sto gruppo? Quali prodotti? Usavamo svariate
tecniche, ma, prevalentemente, costruivamo immagini con disegni o fotomontaggi,
che sottoponevamo a un processo fotomeccanico, ricavandone ratex da colorare o
eliografie in bianco e nero. Ognuno firmava i propri lavori; talvolta li
assemblavamo in quaderni e, in tal modo, con una tecnica semplice e poco
costosa, potevamo avere dei multipli agevoli, per così dire, alla comunicazione
visiva. I risultati formali richiamavano il linguaggio e le tecniche della Pop
Art americana, con implicazioni più marcatamente sociologiche e politiche. In
pratica, avevamo un materiale da portare nelle centrali della cultura dell’epoca
e partecipare a una molteplicità di manifestazioni di avanguardia, senza,
particolari difficoltà economiche. Andammo a Roma alla libreria Rinascita, alla
Feltrinelli di via del Babuino, partecipammo a Barcellona al premio J. Mirò, al
Festival della Cote d’Azur a Cannes, a una mostra a Cuba per un anniversario
della Rivoluzione, a varie manifestazioni in tutta Italia e, naturalmente, della
nostra provincia. Non passammo inosservati, anzi…
Ci scrisse Umberto Eco: "Mi raccomando, tenetemi al
corrente del vostro lavoro…". Ci scrisse ripetutamente e affettuosamente
Luigi Nono. Uscirono articoli sui principali quotidiani, non più quindi le
noticine nelle pagine di cronaca locale. Del Guercio scrisse una lunga
recensione su questi quaderni della Comune. Avevamo l’appoggio e l’apprezzamento
di artisti famosi, Enrico Baj, per esempio; Bertini, Calabria. Mazzacurati disse
che non aveva visto niente di più intelligente negli ultimi decenni in
Campania. Andrea vide che un suo lavoro era stato utilizzato come logo in una
trasmissione televisiva di carattere culturale. Io vidi apparire una mia
eliografia in una sequenza del film Teorema di Pasolini. Insomma, ingenuamente,
ci sembrò che non fossimo più vittime di una atavica emarginazione e credemmo
anche che, quanto ci accadeva, non era mai successo prima agli artisti
casertani. Crescenzo del Vecchio, che lavorava a Napoli, dove, giovanissimo,
già insegnava all’Accademia, col quale c’erano scambi e reciproci
contributi, portava avanti un movimento che poi si chiamò Humour Power (al
quale partecipai col Postal Art). Crescenzo si impose e andò alla Biennale di
Venezia. Alle nostre operazioni si affiancava, talvolta, Vittorio Moriello. Era
ancora un ragazzo, dolce, buono, ma già aveva mostrato la sua forte tempra di
scultore. Più spesso, Antonio de Core. L’indimenticabile Antonio. Un maestro
indiscusso a Caserta. La sua presenza era per noi rassicurante. "Se c’è
De Core – si diceva in alcuni ambienti – vuol dire che è una cosa seria…
Gabriele Marino, anche lui nell’orbita napoletana, manteneva i contatti tra il
gruppo napoletano di Proposta 66 e la nostra Comune. Gli spazi di lavoro erano
quelli del Triangolo, uno studio che Andrea ed io avevamo messo su con i
proventi ricavati dalla vendita di una cartella che Ennio Calabria ci aveva
regalato. In questo Triangolo, si svolgevano le attività del gruppo, si
conduceva una scuola per la preparazione alle abilitazione per l’insegnamento
delle discipline artistiche e si portava avanti l’attività sindacale (le
lotte per l’attuazione della famosa legge del 2%, puntualmente disattesa in
Campania). Qui, nel Triangolo, cominciava a prendere coscienza di sé Giovanni
Tariello, un altro ragazzo che farà parlare, ma anche Carmine Posillipo,
Ribattezzato ed altri, che, con me e Ventriglia, in seguito, formeranno un altro
gruppo: il Junk Culture (Ma quella è un’altra storia). Di tanto in tanto, si
faceva vedere un’artista romana, bella, colta, intelligentissima: Lucia
Romualdi. Anche lei agli esordi nell’avanguardia. Diventerà una protagonista
dell’arte visiva contemporanea.
Una volta, con una lettera di Luca, andammo, Andrea, Raffaele
ed io, da Renato Guttuso, nello studio di Piazzetta del Grillo. All’epoca
Guttuso era vitalissimo e centrale nel dibattito culturale. Noi eravamo molto
tesi. Sapevamo di dover incontrare un grande maestro, le cui opere si trovavano
nei principali musei e pinacoteche del mondo. Insomma le stimmate di una
timidezza provinciale erano fin troppo visibili. A noi si era affiancato un
ragazzo che faceva il militare a Caserta. Era un designer. Diceva di aver
inventato la busta a piramide del latte (e forse era vero). Era assai simpatico
e, certo, precursore di una disinvoltura, che sarà, poi, frequentissima nelle
generazioni successive. Non provava soggezione. Siccome le nostre cose erano in
bianco e nero, Guttuso ci consigliò di esprimerci anche col colore, usando la
tecnica della serigrafia, altrettanto agevole per ottenere multipli e "far
conoscere – disse - in più parti, i risultati del vostro lavoro". Per
rinforzare il discorso, ci mostrò una serigrafia di Enrico Baj, che aveva
ricevuto proprio in quel giorno. A questo punto, il soldato si produsse,
alzandosi anche in piedi, in una vera e propria lezione sulla tecnica della
serigrafia. Renato Guttuso, che aveva spiccato il senso dell’umorismo, non
riusciva a nascondere il riso. Ma il Maestro era anche sottile e ironico,
infatti, nel frattempo, era arrivato il senatore Palermo, un altro guru del PCI,
e lui, Guttuso, ci presentò in tal modo: "Questi sono grandi artisti del
Mezzogiorno…". Quando scendemmo in istrada, camminavamo rigidi, senza
dire una parola, quasi che Guttuso ci potesse spiare da una finestra del palazzo
e sorprenderci in un atteggiamento volgare. Appena voltato l’angolo, però, ci
abbandonammo sia alla gioia per l’accoglienza affettuosa che avevamo ricevuto,
sia all’incazzatura col soldato: "Disgraziato! Ma tu sei proprio un
pazzo!" E roba così.
In quel periodo ci scrisse
Occhetto, allora capo della F.G.C.I.. Un nostro quaderno eliografico piacque a Natta. Ci scrisse finanche
Enrico Berlinguer. Un lungo telegramma. Fu una grande gioia.
E la città? La città ci era ostile. O meglio, noi credevamo
che fosse ostile (forse, inconsciamente, lo speravamo, per sentirci più
rivoluzionari), in realtà, la città era indifferente. Il governo era in mano a
mezze tacche e nei gangli istituzionali s’erano infiltrati i ladri di polli
(poi del pollaio e dell’intera fattoria). Impossibile un dialogo. Impossibile
chiedere appoggi. Un qualche appoggio lo avevamo dagli esponenti del P.C.I..
Gente seria, preparata, severa. Ne temevamo molto il giudizio. Il giudizio
morale e politico, soprattutto. Poi vennero i leader della contestazione e,
infine, i capi dei Gruppuscoli. Ne erano germinati anche a Caserta. Filocinesi,
prevalentemente. Si interessavano alle nostre cose, ma controllavano che anche
noi ci interessassimo alle loro attività e ai loro giornali. Questi giovani
erano più pallidi, più nevrotici. Nei loro ambienti era bandita ogni forma di
umorismo. Parlavano sempre come se il rovesciamento della praxis… fosse una
questione di ore. "Vabbè, finisco di prendere il caffè e vengo o fare la
Rivoluzione…". Mi ricordo che i filocinesi esprimevano la loro
filocineseria in due gruppi differenziati e distinti. Uno, chiamava Mao Tse Tung,
il Presidente; l’altro: il Compagno Mao. Se ti imbrogliavi, come successe a
me, venivi tacciato di piccolo borghese. In quel tempo era un vero e proprio
marchio di infamia.
Ma, piccolo borghesi lo eravamo per davvero. O, più
precisamente: volevamo conciliare un certo decoro, appunto piccolo borghese, con
la boheme e con l’artisticità rivoluzionaria. Senza averne lucidità di
nozione, volevamo conciliare l’inconciliabile. Mi ricordo d’una nottata
trascorsa con Remino a casa sua a lavorare con apparecchi hi-fi (lui aveva una
buona attrezzatura). Mimmo Palladino ci aveva chiesto una colonna sonora, che
facesse da supporto a certe sue installazioni totemiche. Ci impegnammo in un’acrobatica
correlazione, mescolando i canti gregoriani con la musica dodecafonica di
Schoenberg. Al mattino, verso le sette, finalmente finimmo. Con gli occhi
arrossati dalla stanchezza, ma contenti della "commistione" (a
Palladino piacque molto). "E ora – disse Remino – andiamo verso l’altro
polo della schizofrenia".
L’altro polo era il nostro lavoro di ogni giorno. Lui, con
giacca e cravatta, a rappresentare saponi e profumi della Palmolive, nei negozi;
io, meno elegante, a rappresentare teorie e metodi della psicologia scientifica
in disastrate e puzzolenti scuole napoletane. Piccoli borghesi, sissignori! Non
era una vita facile, però. Ma torniamo alla Comune: "Strutture Primarie e
Secondarie per un Teatro Zero".
In quegli anni, a Napoli, esplodevano le avanguardie. In
quest’ambito, il Teatro Esse era uno spazio prestigioso. Si stavano facendo le
prove de "I negri". Genet aveva dato solo a questo teatro, in Italia,
il permesso di rappresentazione. Primo attore: Mastelloni, splendido. Gennaro
Vitiello alla regia.
Conoscevo Gennaro e gli parlai. Gli esposi il progetto. Gli
piacque e la cosa si fece. Andrea aveva mostrato qualche perplessità. Io avevo
dalla mia parte gli altri del gruppo. Andrea, dopo un po’, si convinse e
subito si mise al lavoro, alacremente, come sempre. Ricoprimmo tutte le pareti
del teatro con pannelli neri e installammo delle strutture bianche come la neve.
Non più, quindi, l’uomo-attore a mediare il messaggio, ma queste
strutture-sculture che, in qualche modo, alludevano a categorie sociali e
psicologiche. Per esempio: al sentimento, all’alienazione, alla tecnologia,
alla chiesa, alla sessualità, eccetera. C’era, poi, come un sovraccarico di
espressività, perché queste strutture tra loro parlavano, emettevano suoni. Un
linguaggio piuttosto criptico, ma con una qualche portata metaforica. Tuttavia,
nonostante la parata… dei tropi, l’ammiccamento alla poetica dell’Oggetto
era palese. Non poteva piacere a Luca che, infatti, non ci degnò di una visita;
né vennero gli artisti napoletani di Proposta 66, che, con qualche sporadica
manifestazione, sopravviveva. Vennero, invece, gli artisti e i critici legati a
Lucio Amelio e alla Modern Art Agency. Criticarono, ma, nel complesso, si
mostrarono interessati. L’idea, secondo me, era niente male. Rauschenberg, due
mesi dopo, in un teatro newyorkese, installerà qualcosa di molto simile.
Eppure questa mostra, che in un primo momento sembrava averci
aperto nuovi spiragli e nuovi spazi di ricerca, segnò il principio della fine.
Le ragioni istitutive del gruppo presero ad appannarsi e, in aggiunta,
subentrarono variabili di più basso profilo: l’insofferenza, direi
fisiologica, per l’artista (in generale) alla vita di gruppo; e, poi, qualche
bega, qualche pettegolezzo, che, in una città come Caserta, non potevano non
trovare terreno fertile. Insomma, dopo pochi mesi il gruppo si sciolse.
La fine del Gruppo Studi P.66 – La Comune 2 segnò, per
noi, anche la fine dell’ultima stagione della giovinezza. Una stagione dolce e
amara, rabbiosa e ingenua.
Caro Andrea, da quel tempo ad oggi, sono trascorsi trent’anni.
Quante cose, dopo, abbiamo fatto, o avremmo dovuto fare, quanti cambiamenti
nella nostra stessa coscienza, nelle acquisizioni, quante trasformazioni nel
Paese, nel mondo.
Proprio in questi giorni, l’anno scorso, mi trovavo sulle
rive del Mekong. Ti lascio immaginare le emozioni e l’infittirsi delle
suggestioni per uno della nostra generazione. Noi, la guerra del Vietnam, l’avevamo
seguita nei valori, ma soprattutto, nella rappresentazione quotidiana della
televisione e, poi, nei film di Coppola e Cimino. Ne conserviamo ancora le
immagini nelle icone della memoria. Vive, indelebili.
Ora, laggiù, l’Occidente, sconfitto e cacciato dalla
porta, è entrato dalla finestra con la corruzione e con lo scarto di vecchi
modelli del capitalismo brutale. Di questi modelli si sono appropriati i cinesi
della diaspora che, infatti, tengono in mano tutta l’economia del Sud Est
Asiatico, producendo immani ricchezze per pochi e immani povertà per molti, per
troppi. E i santi eroi? I santi eroi sono morti. Alcuni, deturpati dal naplam e
dalla vecchiaia sono ai margini e chiedono l’elemosina; altri si arrangiano
col commercio delle macchine usate e delle ragazze delle montagne, che valgono
qualcosa perché non hanno l’aids e possono essere vendute in Thailandia nei
bordelli di Bangkok e di Pattaya.
Non voglio parlare della
Globalizzazione, né di Internet,
né dei titoli Nasdaq. Per carità, per carità! Ma devi convenire che le
trasformazioni sono state profonde, e, fino a un decennio fa, impensabili.
Allora mi sono chiesto: i trenta anni che separano gli
accadimenti del nostro piccolo gruppo, dalla vita attuale di un giovane pittore
casertano, l’eventuale utente di una possibile storia, sono trent’anni o
sono trent’anni luce? Sarebbe possibile, oggettivamente, a un giovane pittore
di buona volontà trarre dalla conoscenza di quei piccoli accadimenti, non dico
un insegnamento (non me lo sogno nemmeno), ma una qualche cognizione
utilizzabile per la sua vita intellettuale? Non lo so. Resto nel dubbio. In ogni
caso, caro Andrea, come vedi, ne abbiamo parlato.
Un po’ per gioco e un po’ per non morir….
Affettuosamente
Attilio
|

Andrea
Sparaco
(foto emilio di donato /
archivio "Caserta Musica & Arte")

"Figure
sedute" - 1990
Sculture
in legno

"Monumento
all'inutilità" - 1984
Frammenti
di pino rosso
cm
20x30x40

"Personaggio
con cravatta" - 1986
Tempera,
cm 20x20

China su
foglio - 2001
21x29 cm

"Interno
stravolto 1" - 1981
Tecnica
mista
|